Progetto 'na gita a li castelli'
collettiva di autori del Foto Club Castelli Romani

gli autori: Luigi Conte, Roberta De Marco, Gloria Emili, Elena Lanfaloni, Mariano Fanini, patrizio Paganucci, Serenella Stefani, Claudio Salvi, Edoardo Silvestroni, Mario Vintari
‘NA GITA A LI CASTELLI
L’idea che è posta a base di questo progetto/mostra è tutta nel titolo, copiato da una nota canzone da fraschetta del 1926, portata alla nobiltà dalla interpretazione di quel grande showman d’antàn che fu Ettore Petrolini. Titolo che la definisce e che, volutamente in vernacolo, a caratterizzarne limiti e confini, scimmiotta a sua volta, senza neppure troppi infingimenti, quella meravigliosa operazione fotografica del 1984, dal titolo “Viaggio in Italia”, ideata e curata da Luigi Ghirri e che coinvolse numerosi autori del calibro di Gabriele Basilico, Olivo Barbieri, Vincenzo Castella, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Vittore Fossati, Guido Guidi, Mimmo Jodice ed altri.
Quel progetto/libro/mostra è considerato ancora oggi una pietra miliare per la storia della fotografia contemporanea italiana, e non solo: una sorta di “manifesto” della “scuola italiana di paesaggio” nata nei primi anni Ottanta, subito riconosciuta ed apprezzata, e che ancora oggi resta di grande attualità ed oggetto di studi, approfondimenti, reinterpretazioni e rivisitazioni.
Questo lavoro, analogamente, si propone di operare una profonda riflessione alla ricerca del legame tra l’uomo e i territori che abita, sulle grandi trasformazioni che, in particolare, hanno investito il nostro territorio e sulla mutata condizione sociale ed esistenziale che ne è conseguita. L’idea è quindi quella di ricomporre l’immagine caleidoscopica di un luogo, antropologico e geografico, che si apre ai nostri occhi estremamente frammentato e contraddittorio: non più agreste e non ancora compiutamente e coerentemente urbanizzato, fagocitato dalla vicina metropoli fino quasi a diventarne periferia e tuttavia tenacemente attaccato alle proprie tradizioni.
In altre parole, come la parola “gita” evoca già fin dal titolo, il filo conduttore posto a base è quello di un viaggio per immagini, non tanto (o non soltanto) di tipo turistico o vedutistico, ma teso alla comprensione di uno spazio che cambia, ovvero alla rivalutazione di un paesaggio quotidiano e “minore”, alla ricerca di un’empatia con i luoghi, quasi a preservarne la “memoria”.
L’obiettivo finale non è pertanto la schedatura di un territorio, la resa documentaristica della realtà fosse anche per denunciarne le contraddizioni, né il languore oleografico del viaggio o la rappresentazione formalmente ed esteticamente impeccabile, ma piuttosto il desiderio di entrare in rapporto globale con il territorio dove viviamo; osservare i “nostri” luoghi non per definirli, descriverli o classificarli, ma per proporli come simbolo, espressione e metafora dello spazio contemporaneo, in tensione tra passato e presente.
Ed è così che gli autori, con “occhi puliti” e scevri da ogni pregiudizio, hanno osservato questa terra, già ambita meta dei viaggiatori del “Grand Tour”, ricca come poche altre di Storia e di leggende, di segni e di memorie, ed oggi resa anonima ed omologata da una scomposta antropizzazione che ci ha reso vittime di noi stessi. L’hanno “ri-scoperta” e “raccontata” semplicemente per come è. O meglio, per dirla con Daniel Pennac, “Hanno fatto delle foto. Hanno fotografato invece di parlare. Hanno fotografato per non dimenticare. Per non smettere di guardare.”
Claudio Salvi
Paesaggio quotidiano
La semplice rappresentazione della naturale dimensione del quotidiano costituisce l’elemento fondante di questa ricerca fotografica che travalica i confini stessi della mera rappresentazione o documentazione della realtà per porre all’attenzione dell’osservatore, la continua, inarrestabile trasformazione del territorio e, di conseguenza, del consorzio umano che lo abita, attraverso la riproduzione fotografica delle innumerevoli e manifeste tracce che ne contrassegnano il lungo e interminabile percorso.
La principale intenzione degli autori è quella di rivolgere un esplicito invito alla razionale presa di coscienza della realtà, almeno di quella piccolissima parte di essa che caratterizza il nostro territorio e che costituisce l’umore nel quale, ogni giorno, gli abitanti dei Castelli Romani consumano la propria esistenza, rappresentando, possibilmente, con lucida obiettività e impietosa prosa fotografica, la singolare condizione della propria terra, inevitabilmente vagliandola con il personale filtro della propria sensibilità e cultura.
In questa dimensione quotidiana, nella quale il tutto è in continuo divenire e il passato è saturo di astratta nostalgia, mentre il futuro è percepito appena come un appagamento mentale, la cruda testimonianza dei segni lasciati dall’uomo, anche minimi, costituisce lo strumento più semplice per leggere, conoscere e capire la realtà e, soprattutto, comprendere appieno il senso del cambiamento profondo che sta marcando queste nostre terre.
Senza calcare la mano sugli aspetti sensazionalistici o stereotipati della rappresentazione fotografica, ma dando normale risalto ai comuni segni della quotidianità dell’esistenza umana, la ricerca si snoda lungo un sentiero che parte dalla esplicita ed elementare riproduzione del segno, fino alla possibile formulazione concettuale che può derivare da una più attenta lettura dell’immagine.
La smisurata e incontrollata espansione del tessuto urbano, assieme al caotico mutamento delle funzioni e delle destinazioni d’uso delle strutture architettoniche preesistenti, cambiando il paesaggio in modo radicale, ha profondamente marcato i segni di una trasformazione strutturale e antropologica che se, da un lato, ha offerto agli abitanti di queste terre nuove prospettive di crescita economica e sociale, dall’altro, e spesso, si sono lasciati alle spalle anche fenomeni di estraniazione e alienazione, senza dimenticare lo scotto dell’omologazione.
Si è voluto figurare, perciò, lo scorrere dell’esistenza dentro un paesaggio il cui linguaggio basilare si caratterizza nei suoi segni esteriori essenziali, all’interno del quale si svolge l’apparentemente anonima quotidianità del presente, che rappresenta il terreno lungo il quale si snoda un percorso individuale di ricerca il cui risultato preminente, a prima vista, appare quello di immortalare un istante destinato a diventare passato, più o meno prossimo, ma che, in realtà, costituisce, essenzialmente, la chiara presa di coscienza dell’individuo nell’interminabile e, forse, vano tentativo di comprendere meglio il mondo in cui vive.
Edoardo Silvestroni
Ah! Cchi nun vede sta parte de monno
nun za nnemmanco pe cche ccosa è nnato.
Il giudizio, quasi una inappellabile sentenza, proviene dalla penna autorevole del più grande poeta romano, Giuseppe Gioacchino Belli, che, in un sonetto del 1831, tanto afferma, a sancire lo stretto connubio che unisce l’Urbe ai suoi Castelli.
Un legame che ha fatto dei Colli Albani, un crocevia dove si sono incontrati e fusi, in una fortunata alchimia, Storia, Miti e Leggende, Clima e Natura, personaggi illustri d’arte e cultura, aristocratici di più o meno nobile lignaggio che qui trascorrevano la loro “villeggiatura” e una società rurale formata per la gran parte da pastori e contadini. A far da sfondo Roma, immanente e poderosa presenza come simbolo perenne della classicità e capitale della cristianità.
L’uso della “villeggiatura” ai Castelli affonda le sue radici nel XVIII secolo, come prerogativa di papi, cardinali e della nobiltà romana, usi a trascorrere il i mesi estivi in ville e palazzi che, disseminati su tutto il territorio dei colli, ancora fanno mostra di sé.
A partire dal secolo XIX, la consuetudine si estende a larghe fasce del popolo romano: nacquero allora le “Ottobrate” e le “gite for de porta” che ancora il Belli descrive: “E m’aricorderò sempre a Marino/ indove tutti l’anni annamio fora/ d’ottobre a villeggià co la signora,/ e ce stamio inzinente a Sammartino”.
All’alba del XX secolo un altro importante passaggio cambiò ancora il rapporto tra Roma e queste terre: la realizzazione del sistema tramviario dei Castelli Romani o, per dirla coll’affettuoso nomignolo popolare: “er tranvetto”,contribuì in misura decisiva a far divenire la “Gita a li Castelli” un fenomeno di massa, una abitudine consolidata per tutte le famiglie d’ogni censo e tasca e, non sembri esagerato il termine, un fatto “culturale”, tanto da diventare il soggetto della popolare canzone portata al successo dal grande attore romano Ettore Petrolini e cantata da tanti altri tra cui Claudio Villa, Gabriella Ferri e Lando Fiorini.
Forse proprio a causa di questa quasi “inconsapevole consapevolezza”, la tradizione della gita domenicale è ancor oggi ben viva, nell’immaginario collettivo dei Romani, pur se travolti da una società tanto veloce quanto vorace.
Poco importa che le carrozze e il tranvetto di un tempo siano state sostituite, lungo l’Appia o La Tuscolana, da interminabili file di autovetture di ogni forma, colore e dimensione. Poco importa che un paesaggio meraviglioso, verde e rigoglioso, ricco di vestigia dell’antichità e di clima favorevole abbia perduto la propria antica identità senza assumerne un’altra se non quella di trasformarsi in “paesaggio di margine” della vicina Capitale.
Resta, ora come allora, il desiderio di evasione da un quotidiano oppressivo ed alienante, che una tantum ceda il passo all’ “aria dorce” e alla “magnata”.
Resta una illusione di libertà che da sempre si lega agli spazi aperti, ai boschi, ai laghi, ai vigneti; resta la lusinga di una vita più genuina fatta di semplici e gustosi prodotti locali: le sapide coppiette di carne di cavallo, la porchetta, le fettuccine con “ le rigaje de pollo”e su tutto una abbondante innaffiata di vino di cantina “de quello bbono”.
E resta, forse miracolosamente, dentro ognuno di noi, oltre la realtà qui rappresentata senza compiacimenti estetico-formali o ossessioni di denuncia sociale, qualcosa che ancora ci fa dire con la canzone: “Com'è tutto 'n paradiso! Li Castelli so' così ….. S'annamo a mette lì, Nannì, Nannì.”.
Claudio Salvi
Articoli dalla Rete
Foto della Mostra








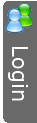
 Ciò che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo una sola volta: essa ripete meccanicamente ciò che non potrà mai più ripetersi esistenzialmente.
Ciò che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo una sola volta: essa ripete meccanicamente ciò che non potrà mai più ripetersi esistenzialmente.